
Oggi è ormai un settore dimenticato dell’economia del paese: ma un tempo era uno dei più importanti

LAVIS. Nella borgata lavoratrice e impegnata di oltre un secolo fa non si praticava e esercitava solamente l’agricoltura, che era peraltro in buona compagnia con i vari mulini, le segherie e le fucine artigianali alimentate dall’Avisio, ma primeggiava anche l’industria serica con la lavorazione, anche casalinga, dei bachi da seta (i cavaleri appunto).
Cavaleri e moràr
1.Questo era uno dei maggiori mezzi di sostentamento di intere famiglie di allora che, oltre ai cosiddetti “cavaleri” allevati all’interno di casa, nelle proprie campagne allevavano anche il gelso (moràr) , in grandi distese vicino ai prati e quasi sempre sui confini perimetrali dei loro terreni. Questa pianta, oltre che dare la foglia per l’alimento primario del baco da seta, dava anche il frutto (le more nere e le more bianche), delizia dei raccoglitori e non solo, ma anche dei ragazzini di quei tempi, ottimo per farne scorpacciate direttamente sulla pianta e per fare le gustose e saporite marmellate casalinghe.
Dalle memorie storiche dei nonni e bisnonni poi era trapelata, per filo e per segno, tutta la storia di questi lepidotteri notturni filatori, i cosiddetti bachi da seta, allevati sulle famose “arele” che erano una sorta di graticcio quadrato, fatto di canne e cannucce, legate saldamente insieme con gli “strami” (i fusti secchi delle piante di granoturco) e vimini (le strope) intrecciati tra di loro.

In tutte le stanze
2.E sempre i nonni raccontavano a noi ragazzini, che le “arele” erano collocate dappertutto all’interno di casa, persino nelle camere da letto dei grandi e dei piccoli; unico locale preservato dall’intrusore “baco” era la cucina, locale dove si svolgeva la maggior parte della vita famigliare quotidiana di quei tempi.
I “cavaleri” subivano una metamorfosi in quattro stadi e il baco allo stato di larva compiva ben quattro mute, chiamate dai più anziani anche con il nome di vere e proprie “dormite”. Intenso era il lavoro giornaliero tutt’intorno alle varie e numerose “arele”, fatto perlopiù dalle mamme e dalle nonne, mentre tutti gli uomini di casa lavoravano nei campi.
Bachicoltura casalinga
3.Bisognava dare ai bachi sempre la foglia fresca, asciutta, pulita e, fino alla quarta muta, tagliuzzata a dovere e adeguatamente. Ogni giorno poi bisognava diradare i bachi, cambiare i letti delle foglie sottostanti e conservare la massima pulizia sia nelle stanze sia degli attrezzi usati.
In tutte le stanze dove soggiornavano i bachi bisognava poi mantenere la temperatura sempre costante (intorno ai 17 gradi), locali sempre ventilati con le imposte semiaperte che si chiudevano soltanto quando fuori faceva veramente freddo. Era un rito vero e proprio quello della bachicoltura casalinga, la cui conclusione avveniva solamente con il recupero del bozzolo intero (galeta) e la sua consegna alla filanda per la lavorazione.

In filanda
4.Nasceva così la seta ( la seda per i lavisani) , quella specie di filo prezioso e miracoloso, prodotto dai bachi all’interno delle pareti di casa. Questo filo sorprendente, sempre a detta degli anziani di casa, era il più sottile di tutte le fibre tessili esistenti anche allora. Il suo spessore e la sua lunghezza variavano però a seconda della diversa razza dei bachi. Diverso era anche il colore del bozzolo, diviso in ben tre classi specifiche: i bianchi, i gialli e i verde chiaro, sebbene qualche esperto aggiungesse che ve ne fossero anche di altri colori intermedi.
I bozzoli arrivavano in filanda dove venivano effettuate le operazioni più importanti della cosiddetta “trattura”. Dopo la “stufatura” (il soffocamento della crisalide all’interno del bozzolo), si passava alla vera e propria scelta e cernita dei bozzoli stessi. Un bel bozzolo, si diceva, poteva dare almeno intorno ai mille metri di filo, quest’ultimo veniva poi ripreso dalle lavoratrici della filanda chiamate “scopinatrici” (scopine per i più nostalgici), poi agganciato e avvolto sul fuso apposito, questa era la seta greggia (o tratta).
Don Grazioli contro la pebrina
5.Un dato storico che ci veniva evidenziato anche a scuola, era quello della produzione locale, proprio a partire dal 1900 nel distretto di Lavis, che comprendeva logicamente le tre frazioni comunali insieme ai vari masi e casolari sparsi sulle colline. Si producevano allora ben 136,130 libbre di bozzoli, si filavano ben 18,100 libbre di seta, utilizzando nelle vaie filande locali ben 207 caldaie a vapore, che davano lavoro a oltre 475 persone d’ambo i sessi, le donne erano in maggioranza però…
Per i bachi da seta nostrani arrivò poi anche l’apocalisse improvvisa, nel senso che arrivò il flagello temuto, quello della pebrina, la malattia detta anche la strofia del baco. Si dovettero cercare altre sementi sane e forti e vi riusci proprio un prete nativo di Lavis, don Giuseppe Grazioli, che con decisione e sangue freddo improvvisò ben cinque viaggi avventurosi proprio in Giappone verso il 1869.
Si portò a casa alcuni contenitori pieni del nuovo seme proprio da Yokoama e così si riprese alla grande la lavorazione dei bachi con questa nuova qualità provvidenziale che creò il nuovo baco lavisano.

L’ex filanda
6.La più grossa filanda rimasta così’ sulla breccia fu quella di Luigi Tambosi in via del Carmine (ora via Degasperi), attrezzata di tutto punto con i più moderni e recenti macchinari del settore, andò avanti fino a tutti gli anni ’30. Poi arrivò la concorrenza della seta giapponese e anche quella artificiale di rayon, tutto minò l’intera attività che culminò fino alla chiusura inesorabile con la grande crisi del 1929.
Dopo il Tambosi la filanda tirò avanti alla meno peggio con la Società Serica Trentina, dal 1947 anche con la Società Tessile Trentina e infine con la Tessile Tamanini di Mezzolombardo. Dal 1955 al posto dei bachi da seta arrivarono i primi radio e televisori dell’Austro Ital concessionaria per l’Italia della Grundig germanica, tutto lo stabilimento venne acquistato dai fratelli Benvenuto titolari appunto dell’Austro Ital. Oggi al suo posto sono ospitati su tutta la zona gli archivi insieme a tutti i magazzini della sede di via Nazionale della Banca Unicredit e si è ipotizzato il trasferimento della Trentino School of Managment.
Le vecchie piante
7.Tanti sono rimasti i ricordi di quelli anni pionieristici ma anche favolosamente inseriti all’interno della borgata. Non esiste più ormai dagli anni ’50, il grande camino che svettava nel grande piazzale della filanda e alto una ventina di metri, al quale erano convogliati i fumi di tutte le caldaie dell’acqua calda per lavorare i “cavaleri”!
E le piante di gelso? Sono scomparse quasi totalmente da tutte le campagne e i prati della zona, qualcuno ricorda ancora quelle interne alla borgata. In centro c’era quella grandiosa pianta di gelso proprio in mezzo al cortile-campagna delle suore Canossiane, una pianta gigantesca c’era anche lungo la roggia tra le case Mariotti- Cadrobbi di via Carmine (ora via Degasperi), altra bella pianta con tante foglie e frutti era quella nella tenuta dei Zippel lungo il confine con la via Orti.
Di aver amato te…
8.Nessuno ricorda ormai più le vecchie “arele” che erano avanzate in ogni casa e che tutti i proprietari hanno poi utilizzato in campagna, nell’orto come addobbo, ma anche quelle tantissime che sono finite come legna da ardere nel camino di casa. L’avventura dei bachi lavisani resta però un ricordo indelebile che si rinnova ogni qualvolta si passa dalla piazza dedicata al “paron de le galete“ (così lo aveva chiamato il poeta Italo Varner), don Giuseppe Grazioli e si rivede il monumento eretto nel 1912 in ricordo proprio della sua grande impresa umanitaria e sociale.
I “cavaleri e le galete” sono stati, per tante generazioni di lavisani, il sostentamento vero e proprio, ma anche croce e delizia di tante, tantissime famiglie di quei tempi indimenticati. La vecchia e cara filanda, infine, rivive ancora tra i ricordi musicali del passato e di quando le giovani lavoratrici di quei tempi cantavano insieme “Le povere filandine” o anche quella de “La Filandera”, canzoni autobiografiche sul lavoro stressante giornaliero.
A portare poi un po’ di allegria moderna arrivò invece intorno agli anni 60/70 anche Milva che cantava a squarciagola la sua canzone “La Filanda” che diceva proprio così: “Cos’è, cos’è / che fa andare la filanda / è chiara la faccenda / son quelle come me / e c’è , e c’è / che ci lascio sul telaio / le lacrime del guaio / di aver amato te…”. Altri tempi, ma anche altre canzoni, purtroppo!

Forse ti può interessare anche:
 In terra vicentina arrivano i due podi di Soddu e Fumarelli
In terra vicentina arrivano i due podi di Soddu e FumarelliUn secondo, un terzo posto e.
 Lavis e il suo percorso storico: dall’ombra di Pressano alla Comunitas Avisii
Lavis e il suo percorso storico: dall’ombra di Pressano alla Comunitas AvisiiPartiamo dalle origini. Ecco il primo.
 Pressano opaco, la capolista Fasano passeggia al Palavis
Pressano opaco, la capolista Fasano passeggia al PalavisI gialloneri di Dumnic hanno perso.
 Troppo Sassari per Pressano, in Sardegna finisce 40-31
Troppo Sassari per Pressano, in Sardegna finisce 40-31Classifica immutata nella parte bassa, ora.
 Pensioni: le novità della Legge di Bilancio 2024
Pensioni: le novità della Legge di Bilancio 2024Una serata organizzata dal Comune di.
 Una raccolta firme per salvare il sito archeologico sul Pristol a Lavis
Una raccolta firme per salvare il sito archeologico sul Pristol a LavisProseguono le indagini nell'area archeologica sulla.

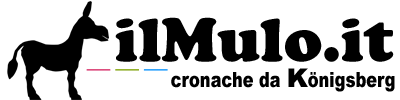
Lascia un commento